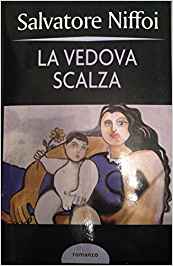 Non avevo mai letto Salvatore Niffoi, nonostante le sollecitazioni di un amico sardo. Qualche settimana fa mi è capitato tra le mani La vedova scalza, che nel 2006 ha vinto il Premio Campiello. Scopro così lo scrittore barbaricino dalla narrazione forte e dal linguaggio che è una commistione tra italiano e sardo. Tuttavia la difficoltà di lettura per termini inusuali non respinge, anzi intriga e sollecita a capire, tanto che lo avvicina, a mio parere, per il sardo, alla ricerca linguistica che Vincenzo Consolo aveva fatto nei suoi scritti con il siciliano.
Non avevo mai letto Salvatore Niffoi, nonostante le sollecitazioni di un amico sardo. Qualche settimana fa mi è capitato tra le mani La vedova scalza, che nel 2006 ha vinto il Premio Campiello. Scopro così lo scrittore barbaricino dalla narrazione forte e dal linguaggio che è una commistione tra italiano e sardo. Tuttavia la difficoltà di lettura per termini inusuali non respinge, anzi intriga e sollecita a capire, tanto che lo avvicina, a mio parere, per il sardo, alla ricerca linguistica che Vincenzo Consolo aveva fatto nei suoi scritti con il siciliano.
Via, anima mia, via da questo sciù sciù di fardette e gambali. Via, che non devi respirare questo alito di morte che s’infila tra le nari e scende nei polmoni col suo odore dolciastro di prugne e mirto.
La vedova scalza racconta di Mintonia Savuccu, sposa giovanissima a Micheddu e altrettanto presto rimasta vedova per l’uccisione a tradimento del marito, datosi alla macchia per l’accusa di banditismo.
“Mira Mintonia, chie a minore s’isposata, a ora e vezza no reposata! Chi troppo giovane si sposa, da vecchia non riposa!”.
L’espediente narrativo di Niffoi è una lettera che Mintonia, poi emigrata in Argentina e nel 1985 ormai prossima alla fine, fa pervenire a una nipote. E’ una sorta di memoriale che racconta tutti gli accadimenti della sua vita in Barbagia, dalla prima infanzia fino alla vedovanza e al successivo espatrio. Ogni capitolo della narrazione è concluso da versetti in sardo, come fosse un coro di una tragedia greca.
Mortu ana a Micheddu / irgannau che unu mannale / onco bos apergiana su cherveddu / a corfos de istrale.
Sono gli anni del ventennio fascista. Taculè è il paese inventato della Barbagia dove vivono le famiglie di Mintonia e Micheddu, amanti e promessi sposi fin da bambini. Lì dettano legge e imperversano il podestà e il comandante dei carabinieri.
I carabinieri, a Laranei e Taculè, tutti li consideravano minci morti, gente che si era arruolata perché ce l’aveva piccolo e voleva godere indossando una divisa. Chi s’infilava dentro una divisa di sbirro per procurarsi il pane da noi era considerato una merdedda, una cacada de pudda.
E, non ultimo tra i personaggi negativi, è l’infingardo parroco don Zippula che il giorno della prima comunione tenta di allungare le mani su Mintonia: “Anticrista! Bagassedda! Anticrista! Bagassedda!”. Politica e questioni personali si mescolano nella Sardegna di quegli anni, un luogo dove basta un nonnulla per sprofondare nell’aldilà: un bicchiere di vino in più, un’occhiata mala, uno sconfinamento di pascolo, un gregge mustrencato, una socca di cuoio, una femmina prinza, una parola di troppo, e tùnfete, il gioco è fatto.
Sono le leggi primordiali di quella terra. Amore e morte, balentia, tradimento, latitanza, vendetta. Mintonia costruisce bene la sua, dopo che ha asciugato le lacrime per la morte di Micheddu, ucciso dalla milizia. Si è istruita per conto suo, ha letto molto, Balzac, Tolstoj, Verga, Manzoni, Grazia Deledda. Ma il richiamo del sangue è più forte.
“Me lo portarono a casa un mattino di luglio, spoiolato e smembrato a colpi di scure come un maiale … Lo stesi sul tavolo di granito del cortile, quello che usavamo per le feste grandi, e lo lavai col getto della pompa … Pthù! Maledetti siano quelli che gli hanno squarciato il petto per strappargli il cuore con le mani e prenderlo a calci come una palla di stracci!”.
Dopo questo libro dovrò fare i conti con la letteratura sarda, a cui non mi ero mai avvicinato, tranne a Sergio Atzeni e al suo Il figlio di Bakunin, letto durante una vacanza a Piscinas non lontano da Guspini dove la vicenda si svolge.
aprile 2024 L M M G V S D « Mar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
